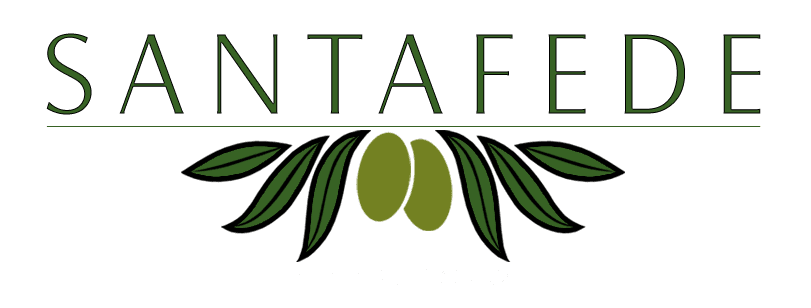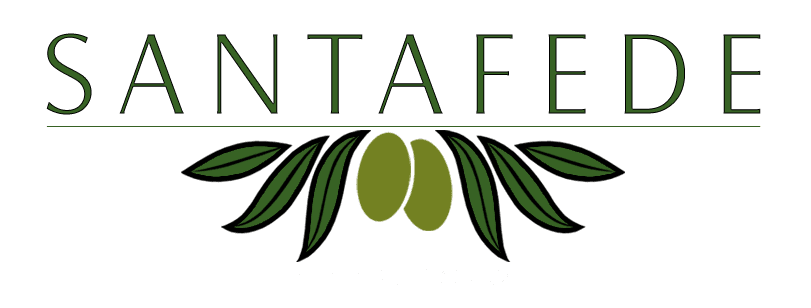«Albero benedetto, ignoto all’Asia, albero invincibile e immortale, nutrimento della nostra vita, olivo color pallido che protegge Atena, la dea dagli occhi brillanti».
(Sofocle, Inno all’olivo)
Sono inconfondibili, gli olivi, non ci si può sbagliare. Non sono alberi qualsiasi come non sono terre qualsiasi quelle su cui si schierano compatti addensandosi in grumi cangianti dal verde all’argento, o in filari a perdita d’occhio, patriarchi dalle teste scarmigliate e i corpi nodosi, disegnati dall’impeto di elementi dalla forza primordiale, monumentali e austeri come cattedrali nelle campagne, a ricordare che il sacro – albero, animale o destino che sia – si offre in forme familiari e “vicine”, come una soglia verso un numinoso più a portata di mano di quanto si creda.
Non terre ordinarie quelle in cui una scala di valori ancestrali addita la povertà e la “barbarie” delle popolazioni nomadi “che non conoscono olio”, dove gli olivi sono un mare di fronte a un altro mare, e i dorsi delle colline isole che affiorano qua e là, nei punti in cui la corrente si dirada e la marea restituisce il colore delle zolle e il senso del limite, e i borghi si scrollano di dosso lo stormire di fronde, i bagliori, i riflessi d’argento tornando a respirare il cielo.
Perché la culla della civiltà è tutta lì. Connaturata dove gli olivi abitano da sempre, docilmente, adattandosi ai mutamenti, alle stagioni, alla sete, all’assenza di forbici o aratri. Gli antichi ricordano che il Mediterraneo comincia e finisce con l’olivo, con quelli che vegliano le orbite ormai vuote e silenziose scavate nella roccia, impolverati dal levarsi del vento che porta con sé i passi perduti, le voci antiche e le tracce indelebili dei sentieri sterrati. Con quelli cresciuti e invecchiati insieme alle pietre millenarie di città scomparse, avvolgendo le radici e il corpo in un viluppo che ne scrive la storia comune. Mentre altri ancora, solitari o in piccoli clan, presidiano con discrezione una corte, un patio, la recinzione turrita di una masseria o la pietra a secco di un trullo, macchiando d’ombra il latte di calce dei muri e disegnando fantasmi di un passato che non si estingue.
Conoscono i bisbigli e le storie di ognuno, gli olivi. Con una statura reale e simbolica che sovrasta le querce, l’uva, il grano, le greggi, i canti, le superstizioni di queste terre di colori e di sapori. Riecheggiano i racconti nel cavo dei tronchi spesso più suggestivi di una scultura d’autore, fatti di contratture, vuoti, equilibri in apparenza precari, trame spezzate e incrinature vulnerabili, modellati con fatica, sofferenza, tempo, rianimati solo dai giochi dei bimbi che ne fanno rifugio e incantesimo fiabesco. Una materia viva e pulsante come una vibrazione all’infinito, cerchi inesauribili che si allargano nell’aria, che il pittore ruvese Domenico Cantatore ha travasato nella sua arte declinandola finanche in lineamenti, scavando i volti legnosi e carichi di umanità dei suoi contadini, facendo dei suoi nodi corpi silenziosi e monumentali sospesi nell’attesa.
Ma quella dell’olivo è soprattutto storia di ogni civiltà mediterranea, che intorno a questi alberi ha scritto i suoi miti e tramandato le sue leggende per spiegare la presenza della prima pianta coltivata sul suo suolo, facendone un simbolo di pace e prosperità, forza della natura e purificazione, tanto che ancor oggi intorno all’olivo sacro ad Atena in vetta all’Acropoli si cammina quasi in punta di piedi, riconoscendo in esso il segno della protezione divina accordata agli uomini.
La tradizione mediterranea vuole che il dono della dea sia stato il migliore che l’umanità potesse attendere dal cielo; per questo Atena e Poseidone avevano gareggiato sottoponendosi al giudizio del padre degli dèi, e a nulla era valsa l’offerta del dio del mare che con un colpo di tridente aveva fatto scaturire acqua salata dalle rocce e un indomito cavallo. L’isola di Creta spiega la suggestiva crescita dei propri olivi a tronco doppio con il premio divino alla devozione di due umili sposi, che lodarono al cospetto degli dèi dell’Olimpo l’ombra d’estate, la legna d’inverno, i frutti nutrienti, l’olio per fare luce, tutti doni dell’albero.
Si confondono, la storia e il mito, senza che l’una possa fare a meno dell’altro, e l’arte – da sempre – fa in modo che quelle raccontate siano storie senza tempo; una pianta d’olivo nasce da un seme proveniente dall’Eden sulla tomba di Adamo, e un ramoscello dello stesso albero torna nel becco della colomba a testimoniare la rinascita dopo il diluvio e a siglare pace e concordia tra il divino e l’umano. Sono presenti, questi alberi, nell’entrata del Cristo in Gerusalemme, nell’orto dell’orazione e sul monte della sua ascesa al cielo, e non mancano mai a punteggiare la campagna fuori le mura delle “città ideali”, come a evocare la superiore qualità della vita frutto del buon governo, la stessa che fa uscire dal pennello di Lorenzetti la pace armata (quella concessa solo dopo la sconfitta del nemico) cinta d’olivo e con in mano un ramoscello della stessa pianta. Si dice che Siena abbia messo un ramo d’olivo persino in mano all’arcangelo Gabriele nei dipinti che raffigurano l’Annunciazione, pur di dimenticare il più diffuso giglio, simbolo dell’odiata Firenze, città che a seguito di una vittoria contro i senesi nel 1260 fece elevare su di una collina proprio un ulivo, che gli avversari potevano ben vedere, “a loro dispetto” e “per ricordare la vittoria”.
Si tratti di paesaggio, di simbolo o visione, la complessità e l’inconfondibilità dell’olivo giungono ai giorni nostri esaltate dagli stati d’animo, e si fanno specchio, eco, riflessione, come nell’albero monumentale di Escher, piantato saldamente nella terra con le sue radici, avvitato con il suo tronco nodoso in una spirale protesa al cielo, con un bianco e nero che sa di vecchia fotografia come un ricordo, una meditazione che sovviene in un momento di solitudine. Come gli olivi così poco “mediterranei” di Renoir, trasfigurati dalle tonalità cupe e dall’effetto del vento, piegati dall’inclemenza degli elementi fino a impastarsi con lo sfondo. Come certa fatica di vivere raccontata dal pennello contemporaneo di Vincenzo Guerrazzi, che intona sempre il paesaggio ai personaggi, evocando fondali cupi, dalle tonalità autunnali, in presenza delle vecchie raccoglitrici vestite di nero, curve sotto il peso del loro lavoro e consumate dalla stanchezza, ma restituendo altre volte le atmosfere nitide e colorate di una danza spensierata inondata dalla luce e scandita con naturalezza da piccoli coni d’ombra.
Mentre i celebri olivi di van Gogh restituiscono il loro fremito sotto la brezza, il loro brillare sotto la luce come in un movimento ondivago e senza margini. In una lettera al fratello Theo, il pittore si rammaricava della difficoltà di cogliere il grigio argento delle foglie, eppure sulle sue tele la compattezza e la consistenza quasi tattile della materia pittorica ne restituiscono persino il tremore. E la voce d’aria, stemperata nella profondità di cieli che sembrano scorrere sulle chiome quasi a volersi congiungere con la terra smossa e ondosa da cui i tronchi affiorano danzando; cieli vibranti ora scaldati dalle tonalità di un crepuscolo che precipita come una pioggia lieve, ora luminosi di azzurri pastosi e densi, macchiati da gomitoli di nuvole irrequiete.
È l’abbaglio del Sud, di ogni sud che si spalanchi agli occhi intorpiditi di chi cerca la luce, la semplicità dirompente di luoghi in cui la terra viene amata e cantata, in cui le tradizioni, i riti, le liturgie hanno radici negli uomini che la abitano. Come racconta La canzone dell’ulivo, terra illuminata di improvvisi bagliori di felicità dalle distese di olivi, nella quale ogni albero è un punto fermo mentre la vita le scorre attorno, un punto di infinito rivolto al cielo che neanche la morte, pur evocata nei versi, rende corruttibile. È l’olio ciò che alimenta il lume, fonte di luce e di vita, è l’olio a bruciare e illuminare la lunga notte dei defunti, da sempre.
Sono inconfondibili, gli olivi, eppure diversi, per ognuno di loro una storia di adattamento e di scambio vicendevole: le radici camminano sotto terra finché non trovano la roccia intorno alla quale continuare ad allungarsi fino ad avvolgerla, colmando ogni fenditura, ogni taglio, ogni vuoto, a intercettare nutrimento e generare vite parallele. A volte si tratta di un’unica cima per due tronchi avvinghiati tra loro quasi come in un abbraccio disperato; una simulazione ad effetto della lotta per la sopravvivenza. Anche contro il vento, che spazza di terra polverosa e profumo di mare, di pollini e fiati piegando gli alberi in un inchino che disegna la curva dell’orizzonte fin quasi a toccare il suolo, lasciandoli così, sotto il peso degli anni che sembra impossibile contare in queste creature credute immortali.
“Debbono esserci isole verso il sud delle cose dove soffrire è qualcosa di più dolce, dove vivere costa meno al pensiero, e dove è possibile chiudere gli occhi e addormentarsi al sole e svegliarsi senza dover pensare“
(F. Pessoa)